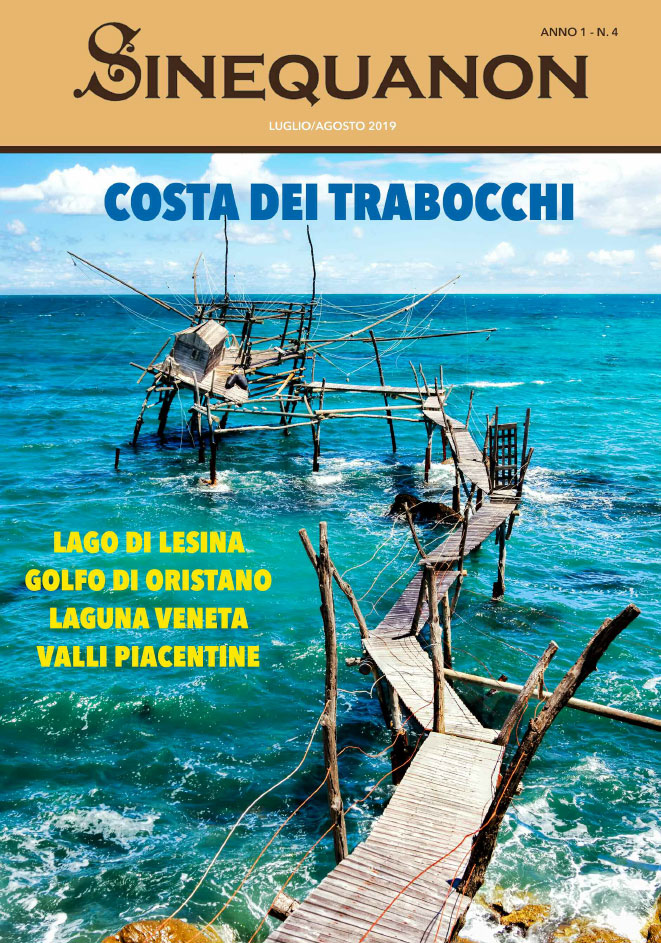Storia, aneddoti e proprietà del più amato degli alimenti
Di Teresa Carrubba
Frutta, miele, neve dell’Etna o del Terminillo: questi gli ingredienti del sorbetto consumato alle mense patrizie degli antichi romani. Una suggestiva variante dello scherbeth, succo di frutta gelato, la cui ricetta fu diffusa in Sicilia dagli arabi. Pare infatti che vada all’Oriente il merito di aver inventato l’algido alimento. In particolare a un discepolo di Maometto che, con un acconcio strumento, rudimentale antesignano delle moderne gelatiere, refrigerava spremute di frutta in un recipiente circondato da neve ghiacciata. La divulgazione in Europa di questo rinfrescante dessert passò attraverso la dominazione mora in Sicilia. Ed è lì che il prodotto mediterraneo manterrà la sua terra di elezione e un punto di riferimento consolidato nei secoli. Di certo, comunque, l’immagine del sorbetto, associata a quella di una coppa ricolma di neve dal lieve profumo di frutta, attrae e stimola la fantasia. E qualche effetto edonistico deve averlo avuto pure su Nerone se, con profondo cinismo, di fronte allo spettacolo di Roma in fiamme, sembrava gustarsi un enorme calice di neve del Terminillo condita con miele e succo di frutta varia.
Nonostante la sua natura effimera, il sorbetto ha dimostrato una notevole solidità arrivando, riveduto e corretto, fino ai nostri giorni. Della sua evoluzione nel passaggio dei secoli si sa ben poco. Salvo qualche accenno nell’arte gastronomica medievale che lo considerava un raffinato intermezzo durante i lunghi e sontuosi banchetti. Usanza di cui oggi viviamo un revival nei menu di rinomati ristoranti. Qualche notizia in più certamente l’ebbe il fiorentino messer Bernardo Buontalenti, famoso architetto scultore e pittore della seconda metà del Cinquecento, notoriamente una buona forchetta e curioso della cucina antica. Si dilettava a rielaborare ricette dei secoli passati e a inventarne di nuove. Sta di fatto che il Buontalenti ebbe un enorme successo quando alla Corte dei Medici fu portato a tavola un dessert inedito su sua ricetta: era nato il gelato. Il manicaretto, gustoso e gradevole, fu ben presto apprezzato presso tutta la nobiltà fiorentina.
La qualità degli elementi e l’elaborata preparazione ne fecero però un prodotto pregiato, non alla portata di tutti. Il gelato, infatti, nato come alimento aristocratico, rimase tale per vari decenni, tanto che la sua successiva diffusione fu considerata una vera e propria conquista democratica. Considerato quindi un piacere riservato alle tavole nobiliari, la sua fama si propagò, almeno all’inizio, solo tra le corti d’Europa. Fu Caterina de’ Medici, sposa di Enrico Il re di Francia, a portarne notizia alla Corte d’Oltralpe. Per averlo assaporato nella natìa Firenze, descriveva personalmente le qualità del gelato ai sovrani degli altri stati, durante i ricevimenti. Caterina non si limitò a esportarne la golosità: volle condurre con sé, a Parigi, un pasticciere perché potesse riproporre, in qualsiasi momento, il miracolo di quella cremosa invenzione.
Sempre a Parigi, un siciliano, Procopio Coltelli, apre nel 1660 il Café Procope, dove si servono esclusivamente gelati su ricetta italiana. Allora regnava felicemente Luigi XIV, il Re Sole, alla cui Corte, considerata un vero modello per l’Europa, si consumavano sorbetti e gelati sia di derivazione medicea sia provenienti dalla scuola del Café Procope. Senza nulla togliere all’arte gelatiera fiorentina, va detto che la diffusione della fredda ghiottoneria ebbe notevole impulso anche dalla Sicilia. Forse per la neve dell’Etna, che rievoca tradizioni ancestrali, o per le profonde tracce lasciate dagli arabi, il fatto è che per la Sicilia, fabbricare gelati è sempre stata una vocazione. Lo testimoniano illustri estimatori della raffinata golosità. In una delle più vecchie e famose gelaterie di Palermo, “Mazzara”, una targa di ottone ricorda le frequentazioni di Tomasi di Lampedusa. Sul tavolino un mantecato o una granita, e intanto scriveva “Il Gattopardo”.
È indubbio che le massicce emigrazioni dei siciliani siano state il più valido veicolo per la diffusione del nostro prodotto. Gli americani hanno assaporato il gelato per la prima volta nella seconda metà del Settecento grazie proprio a un italiano, Filippo Lenzi. E dal diciannovesimo secolo la vera storia del gelato in America coincide con l’evoluzione tecnologica, piuttosto che con quella del gusto. Pietra miliare, la gelatiera a manovella, inventata da Nancy Johnson nel 1864. Il segreto di questa prima sorbettiera meccanica era la possibilità di girare il composto in modo costante, favorendo un raffreddamento uniforme, senza formazione di cristalli ghiaccio. È di Jacob Fussel di Baltimora, invece, il merito di aver ideato l’ice-cream, inteso come mantecato a base di latte, assurto poi ad alimento nazionale. Questa delizia per il palato si deve al caso e a una grossa partita di latte in eccedenza, visto che Fussel, per non farlo deperire, ne fece una crema e la raffreddò. Ancora gli Stati Uniti, e ancora il caso, segnano l’inizio del gelato da passeggio, nel 1892, quando a un gelataio cadde un bastoncino di legno nell’impasto cremoso. Nel tirarlo su, nacque l’idea. Poi è la volta del cono, nel 1904, e del ghiacciolo, vent’anni dopo.